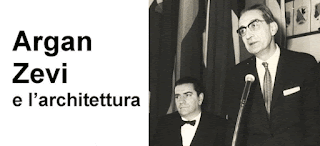Graziella Guidotti
Voli, Ventagli e
Raggiere
Arte in Villa
La splendida
Villa sforzesca di Castell’Azzara (Gr) si è animata con le opere di cinque
artisti che riflettono mondi e diverse poetiche in avvincenti mostre (fino al 19 agosto) per un pubblico che si apre a questo magnifico territorio e prosegue il suo cammino nelle sale dell' affascinante dimora.
Ogni artista
espone in una delle spaziose sale della villa; così le opere tessili di Graziella Guidotti animano
con i loro vivaci colori la luminosa galleria che si apre con tre grandi finestre
sul cortile. Già il titolo della mostra Voli,
Ventagli e Raggiere descrive le opere esposte.
“C’è un’ingiustizia flagrante fra noi due, io
sono stata classificata nelle arti decorative e non hanno voluto ammettere che
io fossi una pittrice in ogni senso”,
con queste
parole Sonia Delunay commenta la differente considerazione riservata alla
propria opera e a quella del marito Robert dalla critica d’arte. Tutto sommato,
“l’ingiustizia figurante” di cui parla la
Delaunay non risiede tanto nel non considerare lei una pittrice, quanto nel
ritenere “minori” le arti decorative. La presenza femminile in questo settore è
da sempre stata approvata: le arti applicate, in particolare il tessile e la
ceramica, sono un esercizio ritenuto adatto alle donne in quanto segno di
operosità domestica. Spesso, però, alla donna era negata la fase creativa: per
esempio, i cartoni preparatori per gli arazzi erano appannaggio degli artisti
uomini, benchè l’esecuzione fosse un fatto prettamente anche femminile.
Nella
seconda metà dell’Ottocento qualcosa cambia: le arti decorative trovano una
nuova dignità e ragione d’essere, destando l’interesse di artisti affermati che
intervengono a salvare dal calderone della nascente produzione industriale. In
questa rivalutazione la donna gioca un ruolo di crescente importanza: da
semplice esecutrice passa ben presto alla fase progettuale, rendendosi
protagonista delle principali scuole di design occidentali. Il caso più celebre
è quello della scuola del Bauhaus, fondato a Waimer nel 1919, che si propone di
affrontare, con criteri lontani tanto dalla tradizione accademica quanto dalle
tradizioni metodologiche delle scuole artigianali dei mestieri, il problema
della produzione industriale, delle nuove tecniche da essa imposte e della
qualità dell’oggetto creato.
In questo
percorso si inserisce Graziella Guidotti, designer tessile con le sue poetiche
opere della mostra Voli, Ventagli e Raggiere.
A base della
loro costruzione la struttura dei tessuti pieghettati che svincolata da
esigenze di uso pratico è diventata tema di una sperimentazione rivolta alla
produzione di pezzi unici. La superficie rugosa, la ricchezza di luci e ombre,
la possibilità di far convivere, con eguale successo, colori in gradazione e
contrasti ha permesso di inventare un grande numero di variazioni declinate in
tante forme differenti fra loro: fantasiosi ventagli che fanno riferimento agli
antichi flabelli egiziani, etruschi e romani, ma anche ai prodotti etnici,
all’arte giapponese e al ricco repertorio elaborato dalle nostre ave lungo i
secoli. Un accessorio-oggetto, il ventaglio, utilizzato fin da tempi antichissimi
in varie forme e con molti significati simbolici: gli egiziani ad esempio lo
associavano al soffio vitale, alla vita stessa, per i giapponesi i suoi raggi
rappresentano le tante opportunità offerte dalla vita e il bordo del pavese o “pagina” la
sua conclusione. Nel teatro NO e nella danza è usato in modo espressivo, come
un vero e proprio linguaggio.
In alcune
opere presenti in mostra, la pagina del ventaglio, è disposta in verticale
anziché in orizzontale e si ripete assumendo un carattere seriale. L’alternarsi
delle sue raggiere orientate in direzioni opposte assume un dinamismo che
suggerisce lo spostamento dell’aria o il soffio del vento ma anche il movimento
di volatili; se disposto in direzione orizzontale, aiutato da una gamma di colori
azzurri e blu, assume e suggerisce il movimento ondoso degli oceani. La loro
struttura è basata sulla lavorazione contemporanea di due tessuti che a tratti
risultano legati a formarne uno solo, altre volte risultano slegati e
indipendenti provocando forti tensioni in ordito e trama, tensioni che, con
appropriati accorgimenti operativi, possono essere modellate in pieghe. Ne
derivano superfici con rilievi ed affossamenti, tutte diverse per consistenza e
colore, ma tutte ugualmente in grado di accogliere luci ed ombre in un gioco
che il comportamento delle fibre da cui sono composte rivelano conseguenze
indeterminate ed imprevedibili in precedenza.
La lezione
dell’astrattismo è, fondamentale per il corso e la storia delle arti applicate.
Secondo Linda Nochilin “le donne artiste, restando fedeli all’antico ruolo di
decoratrici, hanno giovato alla causa dell’astrattismo e allo stesso tempo ne
hanno diffuso il messaggio oltre le pareti dello studio, della galleria, del
museo, nel regno della vita quotidiana”. Come narra, nella presentazione della
mostra, Marina Carmignani, “il lavoro di Graziella Guidotti, si snoda in un
ampio arco di anni, sempre diviso tra l’impegno a tramandare alle nuove generazioni
la complessa struttura delle stoffe e la creazione di tessuti per interni e per
oggetti d’arredo, parti integranti del linguaggio architettonico e di quel
vivace ambito del design italiano dei Sottsass, Aulenti o Michelucci.”.
Le opere in
mostra non intendono emulare il ventaglio e la sua funzione pratica ma evocarne
l’antico fascino attraverso un’interpretazione personale ricca di nuovi valori
e significati, strutture, spesso, sospese in una animazione magica come i
<<mobiles>> di Calder o le accoglienti scenografie di “favole senza
tempo”.
Maria Paola
Forlani